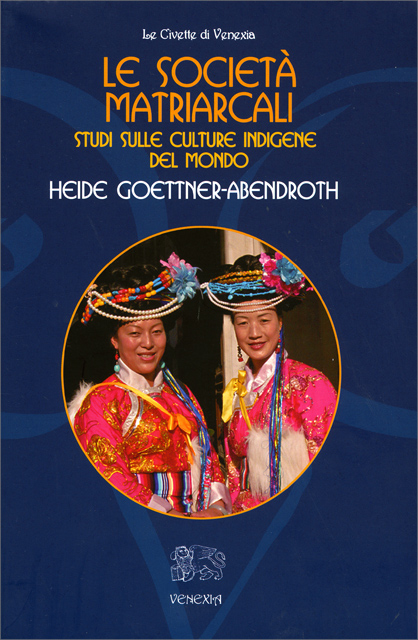Note di vita di Simona Kossak, strega meravigliosa e protettrice di una delle ultime foreste originarie Europee e dei suoi abitanti
“Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire.”
Margherita Hack
Autrice del testo: Elisabetta Spina
Editor e illustratrice: Virginia Elena Patrone
Parco Nazionale di Białowieża in Polonia[1], 1971: una giovane donna con trecce lunghissime e pantaloni di fustagno passeggia tranquilla nella foresta vergine. Porta nella manica un ratto di nome Kanalia e una femmina di cinghiale di nome Zabka la segue come farebbe un cane domestico, mentre Korasek, corvo nero e ladrone che ama aggredire le persone in bicicletta, risponde ai suoi rimproveri come un bambino dispettoso[2].

Simona Kossak, Illustration by Virginia Elena Patrone
Quella donna si chiama Simona Kossak e va in giro nella foresta di giorno e di notte, d’estate e d’inverno, perché lei lì ci vive: nascosta nel cuore della foresta riserva naturale di Dziedzinka, in una casa-rifugio costruita all’ombra di un grande albero tentacolare ma senza elettricità né acqua corrente.
Qui vivrà in per più di trent’anni, dimorando amorevolmente in seno alla natura assoluta. O forse accogliendo la natura a prendere dimora in lei:
“Ho varcato la soglia e mi sono ritrovata dalla parte degli alberi e degli animali. Parlo quindi a loro nome. Ho terminato gli studi in Biologia, ma è stato solo negli anni trascorsi nella foresta che ho imparato a capire il linguaggio degli animali. E lo so così bene ora che dovrei essere bruciata sul rogo come strega“, diceva[3].
E aveva ragione. La nostra Storia, di cui è ormai nota la totale mancanza di prospettiva di genere, chiamava le donne come lei streghe, tacciandole di colpa per il solo fatto di non rispondere pienamente al modello femminile dell’epoca alla quale appartenevano; menti brillanti, talvolta scienziate nate in epoche in cui il sapere scientifico era appannaggio maschile (ricordate Aspasia di Mileto o Ipazia di Alessandria?) o più semplicemente donne forti con la responsabilità di avere idee diverse dal contesto in cui vivevano, con la padronanza assoluta della propria libertà e delle proprie energie. Sì, allora Simona era una strega o forse una Grande Madre sciamana che per trovare il suo posto su questa Terra ha fatto una scelta di vita radicale, tutelando la Natura attraverso la sua passione.
Non sempre avere un cognome famoso è garanzia per l’ingresso nel mondo, a volte può rappresentare un ostacolo. Simona era nata nel 1943 a Cracovia ed era figlia, nipote e pronipote di noti pittori polacchi e inoltre i suoi zii erano poeti e scrittori e lei era cresciuta all’ombra della bella e talentuosa sorella Gloria, pittrice e poetessa[4]. Ammetteva sua nipote Joanna che Simona era “il brutto anatroccolo” nella famiglia degli artisti, “Non dotata di talento creativo“, “un topo grigio che nessuno prendeva sul serio. Per fortuna aveva un carattere forte e la voglia di combattere. Più i suoi parenti la ignoravano, più forte diventava il suo desiderio di dimostrare a se stessa e agli altri che valeva qualcosa“. E poi “Amava gli animali fin dall’infanzia. […] Non la soffocavano con le loro ambizioni familiari, erano la salvezza da un mondo pieno di pretese e valutazioni. […] e potrebbe essere stato il rifiuto che Simona ha dovuto affrontare in famiglia sin da piccola che le ha dato forza di scegliere un sentiero non battuto come stile di vita, e che la sua disillusione nei confronti delle persone le abbia permesso di diventare una difensore dei diritti di chi non ha voce[5].
Ignorate le convenzioni della famosa tradizione familiare, decise di vivere a modo suo, lontana dalla pressione che le imponevano. Laureatasi presso la facoltà di Biologia e Scienze della Terra dell’università Jagellonica di Cracovia, conseguì un master in biologia. Dal 1975 fino al 15 marzo 2007, quando si spense prematuramente, lavorò ininterrottamente presso l’Istituto di Ricerca Forestale del Dipartimento delle Foreste Naturali a Białowieża. La sua attività scientifica, che annovera oltre 140 studi scientifici tra cui significativi lavori sull’ecologia comportamentale della fauna forestale, spicca per la sua vocazione fortemente interdisciplinare, in cui la ricerca è strettamente legata alla protezione e tutela della Natura.[6]
Oltre all’aspetto di ricercatrice, leggendo della sua incredibile esperienza di vita viene subito da pensare che qualcosa di trascendente vivesse in lei: da un lato ci si imbatte nel risultato visibile di anni di studio e di esperienza, frutto dell’osservazione e della tutela degli animali selvatici, dall’altro si percepisce la presenza di un dono, una forza sciamanica cresciuta in seno alla cultura scientifica ma poi affrancatasi da essa per sopravvivere e non esserne spiritualmente assimilata ed assorbita.

Simona with the sow Zabka: Photo by Lech Wilczek
Simona parla con gli animali e per gli animali è come una madre, anzi la Grande Madre delle terre selvagge con il dono divino di guarire corpo e anima con la sua magica energia, l’archetipo primitivo che aveva in sé le somme qualità della creazione e della vita prima di essere relegata al ruolo di madre o sposa o sorella del Dio maschio – come avviene per la religione cattolica- che ne ha assorbito ogni qualità vivifica[7].
Significativa in tal senso è la vicenda del branco di cervi che Simona ha aiutato a crescere per poi andare a vivere nei boschi, i quali, un giorno, esplicitamente la “avvertono” della presenza di un predatore nella foresta salvandola da un pericolo. “Quel giorno ha segnato un passaggio” ha raccontato “Ho attraversato il confine che divide il mondo umano da quello degli animali. […] ancora oggi, quando lo penso, c’è un senso di calore intorno al mio cuore. Esso dimostra come sia possibile l’amicizia con il mondo degli animali selvatici”.[8]
Anche l’episodio dei lupi dimostra come la barriera tra specie possa essere superata: lei nel 1993 inizierà una coraggiosa battaglia per la sopravvivenza dei lupi e delle linci di Białowieża. Infatti, nel 1993 un gruppo di ricercatori del Mammal Research Plant dell’Accademia Polacca delle Scienze progetta di condurre degli studi monitorando lupi e linci del Parco tramite collari trasmettitori, che tuttavia prevedevano violente catture con tagliole e trappole. All’interno della riserva naturale, Simona recupera due di quelle trappole metalliche, le trattiene e si rifiuta di restituirle, venendo accusata dagli studiosi del furto dell’apparato di ricerca[9]. La vicenda venne denunciata alla Procura Regionale di Hojnówka ed alla Seconda Sezione Penale del Tribunale Regionale di Bielsko Podlaskie. Durante l’udienza, in risposta alla domanda su quale fosse la minaccia rappresentata dal metodo di ricerca da lei criticato, Simona rispose: “Ogni animale che cade nella trappola è potenzialmente condannato a morte se la ferita alle zampe è grave. […] è una minaccia letale alla sopravvivenza della lince di pianura, il cui patrimonio genetico è unico in tutta Europa, essendo estinte in altri territori. È una vergogna per il mondo della scienza contribuire a questo”[10].
A seguito la denuncia di Simona vennero rimosse le trappole e, secondo una testimonianza rilasciata dalla biologa stessa, poco tempo dopo un branco di lupi, contrariamente alle loro abitudini, si radunò intorno alla sua casa nella foresta, ululando in segno di gratitudine per aver salvato loro la vita[11].
A ciò si aggiunga che Simona Kossak è stata anche una degli ideatori del repulsore UOZ-1, un dispositivo che avverte gli animali selvatici del passaggio dei treni al fine di prevenire e ridurre gli incidenti provocati dal passaggio della linea ferroviaria nelle rotte migratorie di grandi mammiferi della foresta. [12]
La vita di Simona Kossak è testimonianza di una vita fuori dal comune, spesa in nome di una causa che non si radica né esaurisce in interessi individuali come spesso coltiviamo, ma che trae vigore e determinazione da una natura spirituale che trascende gli angusti orizzonti umani. Ci ha lasciato in eredità un importante messaggio: nonostante esercitiamo il nostro potere tecnico su di essa, dobbiamo assumere la coscienza che siamo tutti ospiti temporanei della Natura, del mondo e, più immediatamente del nostro corpo fisico.
E infine, una donna come Simona Kossak, ha lasciato a tutti noi un’eredità molto importante e profonda da cogliere e diffondere: ognuno con il proprio esempio, con la propria vita può fare – e dovrebbe – fare molto. Noi siamo un tassello sì, ma di un quadro immenso e di valore che si chiama Natura e, in quanto tale, abbiamo il dovere e il diritto di vivere secondo i suoi principi, in armonia con il nostro ambiente e con gli animali che lo popolano e lo condividono con noi.
Autrice del testo: Elisabetta Spina
Editor e illustratrice: Virginia Elena Patrone
Elisabetta Spina è architetto e docente di Storia dell’Arte. Parallelamente alla sua attività di progettazione e insegnamento, si interessa di rigenerazione urbana in collaborazione con associazioni culturali attive sul territorio napoletano e di studi d’ambito storico-artistico interdisciplinari.
Notes & Tips:
[1] Situata lungo il confine tra la Bielorussia e la Polonia, Białowieża è l’ultimo frammento di foresta vergine che si estendeva su tutta l’Europa Centrale. Per il suo grande valore è stata riconosciuta come Patrimonio Unesco dell’Umanità.
[2] Fondamentale testimonianza fotografica della vita e del lavoro della Kossak è il lavoro del fotografo naturalista Lech Wilczek, cui si rimanda.
[3] https://przekroj.pl/en/culture/a-paradise-called-dziedzinka-zbigniew-swiech
[4] https://infowire.pl/generic/release/741875/wwf-patronem-filmu-o-simonie-kossak
[5] “Simone Kossak è il brutto anatroccolo nella famiglia degli artisti“, Agatha Shvedovich dialoga con Joanna Kossak, RAP, 26 febbraio 2017, in https://healthylifepresently.com/it/11520-forest-witch-simone-kossak/
[6] https://www.ibles.pl/-/prof-dr-hab-simona-kossak;jsessionid=3XiBcp6Csbicx1BPgv5ODbf8/en
[7] L’archetipo della Grande Madre “Dea Unica” è legata alla Storia dell’umanità dal per moltissimo tempo, dal 30.000 a.C. fino al 3.000 a.C. ca., mentre successivamente è stata sostituita dalla figura del Dio maschio che ha comunque assorbito in sé le qualità femminili della creazione e del dare la vita, mentre la Dea è stata relegata al ruolo di madre o sposa o sorella del Dio, o come avviene per la religione cattolica di Madre vergine. https://www.archetipi.org/it/mitologia/il-culto-della-dea-madre
[8] Janusz R. Kowalczyk, luglio 2015, https://www.thehumanexception.com/l/simona-kossak/, http://www.shan-newspaper.com/web/astromatta/1783.html
[9] https://www.greenme.it/ambiente/buone-pratiche-e-case-history/simona-kossak-biologa/
[10] https://www.thehumanexception.com/l/simona-kossak/. Purtroppo l’integrità della foresta è stata costantemente sotto minaccia a causa dell’azione umana, vedasi i disboscamenti denunciati nel 2017: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/23/worst-nightmare-europes-last-primeval-forest-brink-collapse-logging
[11] https://www.ehabitat.it/2017/04/21/simona-kossak-biologa-visse-nei-boschi/
[12] https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_Ochrony_Zwierz%C4%85t_UOZ-1